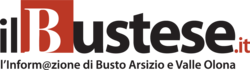I semi della rinascita ci sono già. Si chiamano scuola e cultura, bisogna crederci, saper rinnovare la normalità (più che aspettarne una nuova) e investirvi. Cristina Boracchi, dirigente scolastica del liceo Crespi a Busto Arsizio, esprime questa fiducia. Anche in due armi speciali: coraggio e gentilezza.
In via Carducci, con il consiglio di istituto, spiega «si è deciso di far venire il più possibile i ragazzi, al 75% - e continua – con delle priorità, le classi che arrivavano da accorpamenti, quindi nuove, e le prime, come pure le quinte per l’esame di Stato». Non è solo questione di pur importante socializzazione?
No, nonostante la Dad sia stata demonizzata, è stata preziosa. Cito sempre Massimo Recalcati: certo emergenziale ma preziosa, perché ha dato il ritmo a persone che si sentivano senza socialità. C’è la distanza, però non c’è mai stata lontananza. La scuola è sempre stata vicina ai ragazzi e non si è mai perso tempo. Fin da subito dal 24 febbraio.
Se la didattica a distanza è stata possibile, è anche perché già l’avevate sperimentata?
Sì, ad esempio con i ragazzi ospedalizzati. Già esisteva. Poi, si è vissuta questa accelerazione e abbiamo dovuto riassestare la didattica. Non basta parlare davanti a uno schermo, ma serviva un diverso approccio metodologico.
Che al di là dei disagi ha portato dei benefici?
Sì, nel male della pandemia abbiamo avuto un’accelerazione delle competenze informatiche. Poi quelle dei nostri ragazzi. La nostra scelta è stata quella del sincrono: non del tempo assegnato ai ragazzi per lavorare da soli, ma si è operato insieme. Abbiamo imparato a dare tanti compiti di realtà, perché la teoria diventasse concretezza nella competenza.
Con quali reazioni tra ragazzi e genitori?
Molto diverse. Tantissimi genitori, forse per paura, hanno chiesto di proseguire così, a fronte di altri che pretendevano un ritorno al 100%, non realizzabile alla luce delle misure di sicurezza. E attenzione, non solo sanitaria, bensì anche logistica: corridoi e spazi di uscita. Peraltro in questa scuola abbiamo aperto il più possibile agli studenti. Anche l’amministrazione è molto attenta e noi abbiamo sfruttato al massimo gli spazi, palestre comprese. L’istruzione è il motore del futuro della nazione, l’ascensore sociale si dice da sempre.
Ascensore che si è bloccato con la pandemia?
La Dad sembra averlo frenato, perché i ragazzi con povertà culturali delle famiglie fanno più fatica ad assestarsi. Ma la scuola c’era. Anche con i computer in comodato d’uso, le connessioni, perché c’erano famiglie con presenza di più ragazzi in Dad. Così è stato importante non gravare sui costi della famiglia. Un’altra prova: nel nostro istituto, non si sono verificati abbandoni legati alla Dad.
Il che non significa che sia andato tutto bene, per adagiarsi allo slogan in auge nel primo periodo di pandemia.
Abbiamo notato l’insorgenza di disagi personali. Pochi ma eclatanti, anche se è difficile valutare quanto abbia inciso la didattica esistenza. Poi c’è un bisogno di socialità, ma anche noi l‘abbiamo: vanno educati in un contesto che non è quello di prima.
Che cosa resterà di queste esperienze dopo la pandemia?
A parte attività come il teatro o la corale, corsi pomeridiani e serali, come quelli di russo o giapponese, possono essere mantenuti con le piattaforme. Così come sarà utile con il ragazzo ospedalizzato. O ancora con i genitori, che ringraziano perché ora con l’appuntamento online possono non chiedere il permesso sul posto di lavoro. Sono aspetti che devono essere valutati per il futuro. La pandemia, essendo una crisi, ha portato anche opportunità, vanno colte con coraggio. Per il rinnovo di una normalità entro aree nuove.
Professoressa Boracchi, lei è un riferimento anche nella cultura, pensiamo a Filosofarti, il festival che partirà il 20 febbraio. Portato avanti coraggiosamente, online. Ma che prezzo pagherà la cultura?
Ci sono realtà culturali, che non fruiscono di grandi fondi dello Stato e rischiano la morte. Soprattutto i teatri. Si parla della cultura come se fosse un optional, ma non è così. Alfredo Jaar con i suoi manifesti ne ha ben rappresentato il senso. Ha costruito lo skyline della città, con manifesti e scritte: bisognava spostarli e si trattava di un atto culturale. Si costruiva la polis, la città e la cittadinanza. Siamo immersi nel sentito dire, i social portano purtroppo alla distorsione della comunicazione: basta scrivere quello e diventa vero. Bisogna avere il coraggio di incontrare pensieri che sono anche distanti dai miei, ma mi fanno retroagire con maggiore consapevolezza sulle mie posizioni. È un dovere civico. Filosofarti e molte realtà si reggono grazie a un volontariato culturale, senza oneri per la comunità.
Anche qui, la cultura si è affidata al digitale.
Aiuta mantenere le esperienze, registriamo le conferenze, siamo in streaming e c’è il numero di cellulare per aver domande. La fruizione continua. La presenza fisica, poi, la rivaluteremo come qualcosa di prezioso. Comunque, la cultura ha costi e crea lavoro. Nell’immediato ma anche nell’indotto: esco, vado al ristorante, a teatro. Ecco, non si dimentichi il lavoro della cultura, soprattutto in Italia.
Lei ha avuto occasione di dire: è uno strumento di rinascita.
Sì, di rinascita personale collettiva, sociale, economica.
Una domanda finale, uno sguardo indietro ma sulle sue letture. Quali l’hanno aiutata in questo periodo?
Citerei Carofiglio, Della gentilezza e del coraggio. Una sorta di vademecum educativo al coraggio e alla gentilezza nelle relazioni pubbliche.
Due buone armi per vivere questi tempi?
Ah, sì, si riesce a far arrivare un messaggio, non urlato. In maniera diversa.