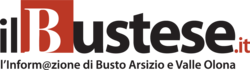Settembre 2007. Angelo si trova nella centralissima via Milano. Viene avvicinato da un gruppo di giovani. Nessun rispetto per i suoi 80 e rotti anni o per la sua corporatura di uomo d'altri tempi che ne ha viste tante. Lo prendono in giro. Lo minacciano. E arriva l’insulto, quello che spiega tutto: «Sporco partigiano». Sì, perché Angelo non è uno qualunque. È Angelo Castiglioni. L’Angioletto. Quello che ha fatto la Resistenza. Quello che è stato deportato. Quello che, essendo sopravvissuto ai campi nazisti e alle marce della morte, è memoria viva. Gli si fanno sotto, tanti contro uno, a deridere la storia sua e quella di milioni di persone. E l’Angioletto resta lì, fino a quando un esemplare del branco, evidentemente soddisfatto, richiama i suoi.
«Lui era fatto così – ricorda Monsignor Claudio Livetti – era retto e duretto. I latini lo avrebbero descritto con il motto “frangar, non flectar”, mi spezzo ma non mi piego. Meno male! Ci ha uniti un rapporto di profonda amicizia». Le minacce di allora testimoniavano una volta di più la necessità della memoria. «Che Angioletto ha saputo trasmettere» sottolinea Livetti: «Tanti, purtroppo, hanno vissuto gli orrori che ha passato lui. Ma in pochi sono stati capaci di raccontare e testimoniare con la sua determinazione».
Considerazione condivisa da un altro amico, Luigi Giavini, che di Busto e bustocchi si intende: «Quando parlava nelle scuole, si creava un'atmosfera irreale. La sua esperienza generava silenzio, rispetto e incredulità. Lui stesso, a volte, si stupiva di quel clima. Trovare certi avvenimenti incredibili e, allo stesso tempo, sapere che si erano verificati davvero: questo creava una sorta di reciprocità tra Angioletto e chi lo ascoltava».
Merito, probabilmente, di qualcosa di intimo che muoveva il partigiano. «Il suo amore – ipotizza Giavini – per la libertà, la solidarietà, la democrazia. Il fatto che non saltasse un consiglio comunale, strumento di democrazia appunto, non è un caso. Se avesse vissuto un secolo, a 99 anni e 364 giorni lo avremmo visto ancora seguire queste passioni, magari in aula consiliare».
«Fece – rammenta Livetti – anche da interlocutore tra chiesa e comune. Il risultato è evidente: oggi il Tempio civico è una scuola permanente di educazione alla pace».
«Una volta – conclude Giavini – riconobbe, non riconosciuto, uno dei suoi torturatori. Che si era rivolto a lui per una pratica, Angioletto seguiva alcune questioni legate remotamente al periodo della guerra. Sbrigò tutto. Poi si presentò con nome e cognome. E porse la mano. L’altro non gliela strinse. Abbassò lo sguardo e se ne andò».
Chissà dove rivolgono i loro occhi, oggi, i giovani "coraggiosi" che circondarono lo “sporco partigiano” nel 2007. Di certo, ricordando Angioletto Castiglioni, si può guardare al futuro.