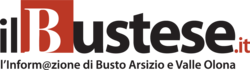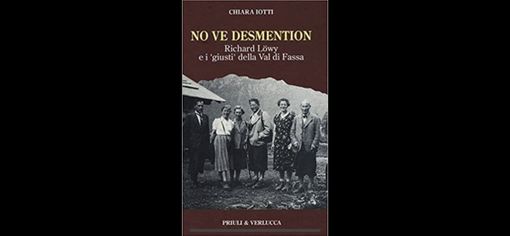Tenetevi liberi, mercoledì 15 febbraio, alle ore 21, alla Biblioteca Comunale “Collodi” di Cassano Magnago, in Via Ungaretti 2, Chiara Iotti presenterà: “No ve desmention - Richard Löwy e i ‘giusti’ della Val di Fassa", un romanzo edito da Priuli & Verrucchi nel 2019.
Nel titolo è riportato una frase in lingua ladina, che in traduzione italiana suona come una promessa: ”Non vi dimenticheremo”, promessa che diventa debito, promessa di non dimenticare il bene ricevuto, debito di restituirlo nonostante i pericoli e la drammaticità della storia, anche a rischio della propria vita.
L’intervista all’autrice, Chiara Iotti, docente di lettere presso il Liceo Crespi di Busto Arsizio, permette di capire meglio la genesi del romanzo, le circostanze dell’ideazione, la storia e le storie che in esso s’intrecciano, i luoghi e le vicende a tratti comuni tra due uomini della storia del secolo scorso, Richard Löwy e Primo Levi, nonché le passioni e gli interessi dell’autrice stessa.
Come è nata l’idea del libro?
«Frequento la Val di Fassa da parecchi decenni, è il luogo delle mie vacanze estive, scelto anno dopo anno poiché mi dona molta gioia, pace, serenità. La mia presenza costante in quei luoghi hanno fatto nascere in me una curiosità via via più intensa verso la storia, le tradizioni, la cultura, la lingua. Ho trovato affascinanti le vicende degli abitanti della Val di Fassa, di uomini e donne che hanno sempre vissuto in un contesto meraviglioso dal punto di vista paesaggistico ma nel contempo difficile. Nel corso degli anni mi sono imbattuta in Richard Löwy , la cui vicenda mi è parsa da subito tanto importante ed interessante, che ho cercato di conoscerla a fondo e di studiarne tutte le vicende, da un punto di vista biografico e storico.
Proseguendo nel lavoro di ricerca mi sono resa conto che la storia di Richard Löwy si intrecciava con quella di Primo Levi, ed è stato allora che nella mia mente è nata l’idea di annodare i fili di due percorsi diversi e lontani che solo io potevo annodare. Come docente di lettere al liceo spesso faccio leggere e studio le opere di Primo Levi, autore che amo molto, presentato e approfondito ogni anno nelle mie lezioni, il viaggio ad Auschwitz, svolto con la scuola, la visita ai campi di sterminio, visti direttamente, con i miei occhi, hanno fatto il resto. Ha preso forma l’idea di scrivere un romanzo che intrecciasse alcuni “fili” o “temi” importanti per me: l’amore per la montagna, l’amore per la letteratura, l’amore per Primo Levi e le sue opere, l’amore per un personaggio così affascinante come , Richard Löwy e la sua storia, il tema della testimonianza».
Quali altri fattori hanno giocato a favore della stesura del romanzo?
«Si è verificata un’altra straordinaria coincidenza: da piccola, durante le mie solite vacanze estive, in val di Fassa avevo conosciuto delle persone che, ho scoperto anni dopo, essere state vicine Richard Löwy; in particolare una signora anziana, che io chiamavo “nonna Luigia”, aveva conosciuto personalmente e in modo diretto il protagonista di quello che stava diventando “il mio romanzo”, un romanzo carico di valenze plurime: i miei ricordi d’infanzia e tutte le mie passioni»
Come ha iniziato a scriverlo?
«Per prima cosa ho cercato di raccogliere il maggior numero di notizie sulla biografia di Richard, e in questo il mio lavoro è stato facilitato dalla lettura della biografia ufficiale di Richard Löwy, realizzata da Carlo Jellici, che è il nipote di una delle più grandi amiche di Richard, la maestra Valeria Jellici. Io, però, non avevo intenzione di scrivere una biografia, volevo scrivere un romanzo, poiché ritengo che sia la forma letteraria più adatta ad esprimere i sentimenti, le esperienze e i pensieri di Richard Löwy e delle persone che gli sono state vicine.
Ho deciso allora di costruire il romanzo su una doppia linea temporale, che mi permetteva di sviluppare una doppia linea narrativa ambientata in due tempi diversi: la prima è quella del presente, ambientata nel 2008, quando una ragazza arriva in Val di Fassa per le sue vacanze estive, e qui, entrando in contatto con una nonnina (“nonna Luigia”), scopre la storia di Richard Löwy, soprannominato dall’anziana signora “il santo ebreo”; da tale scoperta si apre il secondo tempo e la seconda linea narrativa, quella ambientata nel passato, tra le due guerre, nella quale si snoda la vicenda del “mio” eroe»
Quali aspetti della vicenda biografica di Karl Lowy l’hanno colpita di più?
«È necessario fare una premessa: Richard era un tenente dell’esercito austroungarico, arrivato in Val di Fassa nel corso della Prima guerra mondiale. La valle in quel tempo era parte dell’Impero Austroungarico e, nel 1914, all’inizio della Grande Guerra, quando Richard vi giunse, aveva 30 anni ed era ingegnere, arruolato come tenente nel genio dell’esercito austroungarico. Con il tempo il tenente austriaco fece carriera: impegnato nella costruzione di strade, ponti, trincee e fortificazioni utili ad armare e a difendere questi territori, divenne comandante del genio. Nel frattempo i giovani Fassani erano andati a combattere contro l’Impero Russo in Galizia, una regione storica e geografica che si trova al crocevia dell’Europa, al confine tra Polonia e Ucraina. In quel periodo Richard si prodigò a favore di Moena, ne fu un grande benefattore, egli infatti si diede da fare per tenere i giovani uomini del paese in valle, dicendo che ne aveva bisogno per costruire le trincee e fece di tutto per aiutare gli abitanti di Moena nel corso della Prima guerra mondiale. È noto a tutti che tale conflitto avrebbe dovuto essere una “guerra lampo” e invece fu una guerra molto lunga e di logoramento, che mise a dura prova la popolazione di queste zone, soprattutto nel 1918, l’anno della “grande fame”.
Löwy aiutò i giovani uomini locali a rimane nelle loro terre, a non essere inviati al fronte, lontani da casa; aiutò anche le donne di Moena, realizzando per loro una sartoria e una lavanderia militare, nelle quali lavorare, percependo delle entrate economiche fisse, in un periodo di stenti e ristrettezze per tutti. Realizzò, inoltre, alla fine della Grande guerra un lazzaretto per l’assistenza e la cura degli ammalati di colera. Per tutte queste ragioni e meriti ottenne la cittadinanza onoraria di Moena.
Come prosegue la vicenda di Richard?
Ad un certo punto la narrazione della sua storia si interrompe, per riprendere molti anni dopo: è il 1938 e Richard vive a Vienna, con sua moglie, Johanna Liebgold, quando inizia a rendersi conto che in quel momento per un ebreo tedesco, come lui, vivere in Austria è molto difficile e pericoloso. Ottiene un permesso per trasferirsi in Italia, l’unico paese verso il quale riesce ad espatriare, e, l’unico nel quale si sente di poter avere una nuova patria. Così Richard torna a Moena, dapprima ospitato dal comune, dalla gente del posto, poi, quando, dopo il 1943 c’è l’armistizio, e questa zona passa sotto il controllo diretto dei tedeschi, lui comincia a temere per la sua vita ed è costretto a nascondersi. Quindi, dal 1938 al 1944, Richard, con la moglie e la sorella Martha, il cognato Hermann e la mamma Edvigh, stanno a Moena e a Soraga, nascondendosi dalle autorità fino al giorno in cui vengono arrestati. Non sorprende scoprire che gli fu possibile nascondersi a lungo grazie all’aiuto dei cittadini di Moena, che, memori del bene ricevuto da Richard Löwy, quando rappresentava l’autorità e la forza, gli restituiscono l’aiuto ricevuto proprio nel momento in cui lui rappresenta la debolezza.
L’espressione ‘giusti’ nel suo romanzo ha quindi una duplice attribuzione, se ho capito bene. Può spiegarcelo?
«Esattamente. Nel mio romanzo ho usato la categoria dei ‘giusti’ per parlare sia di Richard Löwy per l’aiuto dato agli abitanti di Moena quando ne ebbe facoltà, sia dei cittadini di Moena, che lo hanno nascosto quando lui si trovò in condizione di bisogno, tentando di salvarlo, i “giusti della Val di Fassa” citati nel titolo, per l’appunto».
Può darci qualche indicazione sui luoghi e l’ambientazione del romanzo; che importanza hanno?
«Ovviamente dietro ad ogni romanzo c’è un luogo. Nel mio l’ambiente è un luogo che ha una particolarità: è una terra di confine, confine tra il mondo germanico e il mondo italiano, nel quale è presente un’isola ladina, un mondo nel quale si parlano tedesco, italiano e ladino. È inoltre una terra di montagna, che come tale, ha sempre prediletto i passi, rispetto alle cime. Noi turisti abbiamo una visione della montagna che mira alla cima, alle vette, gli alpinisti ammirano la bellezza della cima, hanno il gusto della scalata per arrivare alla vetta; gli abitanti della montagna, invece, i “montanari” sono interessati ai pascoli e ai passi, poiché sono i luoghi che permettono loro il passaggio da una parte ad un’altra, dove possono incontrare altra gente. I passi sono la grande occasione della montagna, per chi vi abita stabilmente, perché sono un luogo di scambio e d’incontro. Il passo, quindi, per chi arriva da valli diverse, confinanti, non è un luogo che separa, al contrario è un luogo che unisce e permette l’incontro.
La Prima guerra mondiale, fu, purtroppo combattuta proprio sui passi di montagna, ad esempio sul Passo San Pellegrino, il Passo Rolle e tanti altri, proprio per questioni di conquista dei confini, intesi come linea di demarcazione, separazione e di possesso di un territorio. La concezione del confine negli scontri bellici assume un significato opposto a quello originario. In tempo di pace le terre di confine sono luoghi nei quali è possibile un altro modo di vivere, un modo nel quale si sta insieme agli altri e le diversità non sono necessariamente elementi negativi, al contrario una opportunità di ricchezza reciproca».
Per approfondire il tema e conoscere meglio l’autrice e il suo lavoro di scrittrice, si forniscono di seguito il link al suo blog per altri interessanti approfondimenti: https://chiaraiotti.com/