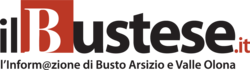Giuseppe Trabucchi. Oculista. Dirige da oltre 20 anni la “sua” Unità Operativa Complessa, a Legnano. Un ruolo interpretato con la competenza indispensabile al medico e con la passione utile a varcare i confini dell’ambito lavorativo. Ad “andare oltre”. Lo dimostra, fra l’altro, il volume “L’occhio nell’Antico e nel Nuovo Testamento”, firmato dal dottor Trabucchi e presentato ieri a Villa Jucker, nel corso di una serata-evento della Famiglia Legnanese. Sedie distanziate ma sala gremita, pubblico attento e partecipe. Opera in distribuzione a offerta libera e ricavato destinato alla parrocchia di San Magno.
L’incontro è stato moderato dalla giornalista Cristina Masetti e introdotto da monsignor Angelo Cairati. Che all’opera ha contribuito, fra prefazione e consulenze. Il prevosto, muovendo dalle Sacre Scritture, uno dei due perni del saggio, ha presentato la religione cristiana come ossimorica «… perché accosta realtà pressoché incompatibili. Chiede di credere in un Dio che si è fatto uomo, nella vita dopo la morte, chiede di amare il non amabile. Però la narrazione cristiana, laddove praticata con coerenza, ha forgiato uomini di pregio, di buona stoffa. Nel battesimo ci sono stati dati gli occhi della fede. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo sesto, si legge: La lampada del corpo è l’occhio. Se, dunque, il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato».
Il primario, come si sarebbe detto un tempo, ha presentato il volume partendo dall’esperienza quotidiana. Quella di chi guarda negli occhi le persone. Occhi sempre diversi, che comunicano. E che portano alla domanda: «Da dove viene tutta questa potenza? La scienza ha fatto tanto. Ma, da cristiano, sono convinto che l’uomo non potrà mai sapere tutto». Il medico ha ricordato l’esperienza preziosa scaturita dalla partecipazione alla “Scuola della Parola” e la genesi di un percorso. Quello per «…cercare le volte in cui occhio e visione trovano risvolto nelle Sacre Scritture».
Una ricognizione che non poteva prescindere da argomenti legati alla professione, ricchi di significati: «L’occhio fisico ha la funzione di ricevere la luce per portarla al cervello. Ci consente di relazionarci col mondo, con tutto il nostro ambiente. Anche se della visione ancora non conosciamo tutto. Dall’altra parte, l'occhio è la finestra attraverso la quale gli altri possono guardarci dentro».
L’indagine. Fondamentale la distinzione fra Antico e Nuovo Testamento. Nel primo, Dio è invisibile anche se «…lo sguardo di Dio verso la creatura umana non cessa mai». Un esempio su tutti nella Genesi: dopo avere mangiato il frutto proibito, Adamo sfugge («…ero nudo e mi sono nascosto») ma Dio sa già, lo ha visto. «L’uomo ha uno sguardo finito, anche se pensa di potere vedere l’infinito» ha tirato le somme Trabucchi.
Passaggi dedicati al libro dei Salmi: «Pensate alla vita dei pastori in tempi durissimi, al loro bisogno di Dio, al bisogno di guardare il cielo e di pregare, per richiesta e per ringraziamento». Inciso dedicato al ricordo visivo, recente, di Papa Francesco che attraversa, claudicante, solo, piazza San Pietro in piena emergenza Covid («E' il momento di chiedere, disse il telecronista»). La citazione, a giudizio di Trabucchi importante per medici e pazienti (in sintesi, per quanti vivono nei diversi ruoli la malattia) di Giobbe. «L’occhio mi si oscura per il dolore, dice. E Dio si mette di fronte a Giobbe. Dialoga. L’occhio dell’uomo va rispettato».
E il Nuovo Testamento? «Lì il Verbo si fa carne. Appare il volto di Gesù e il suo sguardo si posa sull’uomo, su chi sta con lui». Diventa più forte il tema della luce. «Complesso, teologico, profondo – ha affermato l'autore – ma è ovvio che senza luce non c’è vita, è la prima cosa detta nella Genesi. E poi c’è la stella, alla nascita di Gesù, che illumina i pastori. Luce che consente di non perderci, contrapposta alle tenebre».
Inevitabile un approfondimento sul miracolo del cieco nato. «Un cieco – ha ricordato il medico e il credente - era un uomo solo, abbandonato, un ultimo. A quei tempi i problemi all’occhio erano quasi incalcolabili: traumi, patologie, danni prodotti dai fattori ambientali. E la malattia era peccato. La guarigione del cieco è l’aprirsi a una vita nuova».
Senza dimenticare le vite terrene, più vicine, di chi è “venuto prima”: «Il libro è dedicato a mio papà e mia mamma». Di nuovo un confine varcato, di nuovo un andare oltre.