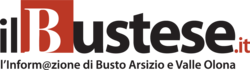Legnano ha celebrato il Giorno del Ricordo, giovedì 10 febbraio, intitolando i giardini compresi tra le vie Abruzzi, Sardegna e Ancona (quartiere San Paolo) ai “Martiri delle Foibe e agli esuli giuliano-dalmati”. L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale e da Anpi Legnano, nasce dalla richiesta di intitolazione presentata l’anno scorso dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e approvata dal consiglio comunale. Durante la cerimonia gli interventi del sindaco Lorenzo Radice e del professor Giorgio Vecchio, che riportiamo integralmente.
Intervento del sindaco Radice in occasione del Giorno del Ricordo
Buongiorno a tutti, alle autorità civili e militari presenti, ai rappresentanti delle associazioni, ad Anpi che ringrazio per aver collaborato nell’organizzazione, ai cittadini e un saluto particolare a voi studenti delle terze classi delle scuole “Levi Montalcini” che realizzate con noi questa cerimonia. Oggi Legnano aggiunge un tassello nella costruzione di quella che ci piace chiamare la “Città della memoria”, una Legnano fatta di segni -siano questi targhe, steli o pietre d’inciampo- che rimandano a persone o a episodi della storia locale e nazionale. Oggi, Giorno del Ricordo, Legnano intitola quest’area verde del quartiere San Paolo ai “Martiri delle foibe e agli esuli giuliano-dalmati”. E io voglio essere molto chiaro a proposito: per fare veramente memoria serve, in primo luogo, una profonda onestà intellettuale e la forza di trovare ciò che unisce. Serve essere pronti a riconoscere, senza preconcetti, meriti, colpe e responsabilità che hanno dato origine agli eventi della storia, e specie ai più controversi. E quello delle foibe e dell’esodo di tanti italiani è senza dubbio uno di questi. Negare questo fatto significa mentire. Significa far finta di nulla. Vorrebbe dire ignorare le enormi difficoltà che ci sono state nei quasi ottant’anni che ci separano da quei fatti drammatici nel riconoscere le responsabilità di quanto accaduto e nel raggiungere, con grande fatica, una visione condivisa. E questo – bisogna ricordarlo – è un risultato recente: la legge, quella che istituisce il Giorno del Ricordo risale al 2004, mentre è del 2006 la prima celebrazione di questa solennità civile nazionale.
Allora, voglio rivolgermi a voi studenti delle “Levi Montalcini”: cosa significa, secondo voi, arrivare a celebrare per la prima volta un fatto storico circa sessant’anni dopo quell’avvenimento? Cosa può essere successo in tutto quel tempo? Come è possibile che per mettersi d’accordo su dei fatti successi negli anni Quaranta sia stato necessario così tanto tempo? La mia risposta è semplice: io penso che ognuno, per tanto tempo, sia rimasto sulle proprie posizioni e non abbia voluto ascoltare gli altri. Per tanti anni c’è stata quella situazione bloccata che si chiama “muro contro muro”, perché ognuno ha guardato ciò che ci aveva diviso piuttosto che ciò che ci accomuna. E nel muro contro muro cosa succede? Che è giusto soltanto quello che penso io e che gli altri, quelli che non la pensano come me, sbagliano. È chiaro che il muro contro muro non può portare da nessuna parte. Cosa succede, del resto, a scuola quando litigate fra compagni di classe? Picchiarsi, insultarsi, fare i bulli serve forse a capirvi meglio o a mettervi d’accordo? Sapete benissimo che litigare e combattersi non porta mai a niente in ogni situazione della vita, quindi non può essere d’aiuto nemmeno quando si prova a ricostruire e dare un senso ad avvenimenti storici drammatici come sono state le foibe e di cui vi parlerà fra poco, da vero storico, il professor Giorgio Vecchio, che ringrazio. La mostruosità delle foibe nasce proprio da una situazione di questo tipo; anni di incomprensioni, di ostilità, di razzismo, di violenze continue e crescenti. E voi, ragazze e ragazzi, sapete bene che la violenza non risolve i problemi. La verità è che la violenza, i problemi, li crea. Anzi: è la violenza stessa a essere il problema, uno dei problemi più grandi nella storia dell’umanità. E questo perché violenza genera violenza in una spirale da cui si rischia di non uscire più. Che cosa possiamo fare, allora, per non ripetere gli errori del passato, per non riprodurre nei giorni e nella realtà che viviamo contrapposizioni che sono distruttive? La risposta è parlarsi. Parlarsi per ascoltare l’altro e le sue idee, e non per imporre a ogni costo le nostre. Questo è il compito, a ogni livello, della buona politica: partire da posizioni anche molto diverse e riuscire a trovare un’intesa. Ma questo risultato si può ottenere a una sola condizione; la disponibilità a confrontarsi seriamente affrontando nel merito le questioni. Che, in questo caso, significa anche dover ammettere cose che possono dispiacerci, cose che è difficile voler riconoscere. Ma questo e soltanto questo è fare veramente memoria. Non c’è altra strada: se non facessimo così, se affrontassimo questi temi nei soli aspetti che ci fanno comodo tutti noi saremmo responsabili dell’ occultamento di una parte essenziale della verità. E sarebbe fare un torto ulteriore ai tanti innocenti massacrati e agli italiani costretti ad abbandonare le loro case cui oggi intitoliamo questo spazio. È con questo spirito che, qualche mese fa, il consiglio comunale di Legnano ha votato all’unanimità l’intitolazione di un’area pubblica ai martiri delle foibe e agli esuli giuliano dalmati. E questo perché un argomento che è sempre stato divisivo e motivo di contrapposizioni potesse finalmente diventare un patrimonio del sentire comune: tanto dobbiamo a chi, quasi ottant’anni fa, ha perso in modo terribile la vita e, con dolore, è stato sradicato dai luoghi in cui era nato e vissuto fino a quel momento. Intitolando questo spazio verde non pretendiamo di dare una lezione di storia. La nostra intenzione è piuttosto quella di lanciare un messaggio: parliamoci e confrontiamoci rispettandoci sempre, pur nella diversità delle nostre vedute. Affermare una ragione per annullare tutte le altre ha prodotto, nel secolo che ci siamo lasciati alle spalle, atrocità bestiali come le foibe, i lager, i gulag, luoghi in cui c’erano uomini che si consideravano superiori rispetto ad altri uomini, quindi legittimati a eliminarli; luoghi di cancellazione, separazione e morte cui opponiamo la memoria e i luoghi di incontro e di vita, come questo giardino pubblico. Costruiamo punti di incontro e cerchiamo sempre ciò che ci unisce prima di ciò che ci divide, perché quello che è accaduto non deve accadere mai più. E tutti noi, nessuno escluso, dobbiamo impegnarci, nelle nostre vite, nei nostri comportamenti quotidiani, dal lavoro alla politica alla scuola affinché il seme dell’intolleranza non dia mai più i suoi frutti velenosi. Grazie a tutti e buon Giorno del Ricordo.
Giorgio Vecchio
Perché rendiamo onore oggi alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata?Quali vittime? Quali esuli? E perché ci sono state vittime ed esuli? Cerchiamo di orizzontarci. Spostiamoci con la fantasia verso est, verso il mare Adriatico e le coste della Slovenia e della Croazia, più precisamente nella penisola dell’Istria e lungo le rive della Dalmazia. Splendide terre, con spiagge, scogliere e città ricche di storia, nelle quali sembra ancor oggi di essere a Venezia, perché ovunque svettano campanili e leoni di San Marco. Lì vivevano, abbastanza pacificamente, persone di lingua e cultura italiana, specie nei centri lungo la costa, insieme a sloveni e croati, per lo più residenti nelle campagne dell’interno. Però, su tutti, alla fine dell’Ottocento, cominciò a soffiare il vento del nazionalismo: per gli italiani, gli slavi andavano considerati inferiori; al contrario, per gli slavi, gli italiani erano degli oppressori da cacciare. Al termine della Prima guerra mondiale, quelle terre – l’Istria e la città dalmata di Zara – furono conquistate dal Regno d’Italia e divennero province italiane. Il governo di Mussolini impose l’italianizzazione forzata e represse con durezza quegli sloveni e quei croati che pretendevano il rispetto delle proprie tradizioni e della propria lingua. Dall’altra parte del mare sorse invece un nuovo Stato, dalla vita difficile e turbolenta, che si chiamò Jugoslavia, ovvero lo Stato degli slavi del sud. Qui le diverse etnie presenti – specie i serbi e i croati - continuarono a guardarsi con ostilità.
E adesso spostiamoci nel tempo, mentre infuria la Seconda guerra mondiale. Il 6 aprile 1941 truppe italiane e tedesche invadono la Jugoslavia, che si dissolve. Inizia un periodo di scontri armati, nei quali gareggiano per ferocia i tedeschi, i croati, i serbi e, purtroppo, anche gli italiani. Si scatena la caccia all’ebreo. Sulla scena irrompono i partigiani jugoslavi comunisti, guidati da un uomo che si fa chiamare Tito.
L’8 settembre 1943 viene però annunciato che l’Italia si è arresa agli Stati Uniti e ai loro alleati. Lo Stato italiano si sfascia, il Regio Esercito si disperde e, mentre la Germania nazista inizia la conquista totale del nostro territorio, alcune regioni rimangono fuori da ogni controllo. Lì può scatenarsi la violenza di chi ambisce al potere o alla vendetta. È il caso della Venezia Giulia, di cui fa parte l’Istria.
Tra aprile e maggio 1945, invece, termina finalmente la guerra. Il regime fascista di Mussolini scompare definitivamente, ma l’Italia è in una condizione drammatica, costretta alla fame, sotto un cumulo di macerie e deve piangere 450.000 morti. Nelle nostre province orientali si sono installate le formazioni partigiane jugoslave, che – loro sì – la guerra l’hanno vinta.
Inizia un nuovo periodo di violenza. Ebbene, in quelle terre – in modo particolare in Istria, alle spalle di Trieste – esiste una particolarità geologica: le foibe. Cosa sono? Sono dei profondissimi buchi naturali nel terreno, come degli imbuti, che la popolazione locale usa spesso anche come discarica. Ed è in queste foibe che – dapprima nel 1943 e, in misura maggiore, nel 1945 – vengono fatti cadere i corpi di molte persone, uccise sull’orlo del baratro. Le vittime sono quasi sempre italiane, ma talvolta anche jugoslave; gli assassini sono jugoslavi. Viene inventata una nuova parola, orribile: gli “infoibati”, che poi però viene estesa a tutte le vittime, anche se uccise in altri luoghi, per esempio in campi di concentramento o in carcere o fucilati altrove. Il numero di questi morti è molto alto, anche se non sapremo mai la cifra esatta: da 4.000 a 12.000, calcolano gli studiosi più seri. Forse anche di più.
Tra gli uccisi – dicevo – ci sono soprattutto persone di lingua e cultura italiana, chiamate a pagare un conto pesantissimo. La loro colpa? Quella, appunto, di essere tali: agli occhi dei loro carnefici, infatti, essi rappresentano quello Stato italiano – lo Stato fascista – che li ha oppressi per vent’anni. Un motivo politico, dunque, che però non fa distinzioni, acciuffa chi può, non si preoccupa eventualmente di celebrare giusti processi e così confonde innocenti e colpevoli.
C’è però di più. Gli assassini sono militanti della parte vittoriosa della Resistenza jugoslava, quella comunista guidata da Josip Broz, il leggendario Tito. Il loro progetto non è soltanto quello di instaurare un regime autoritario, sul modello di quello sovietico di Stalin, che non lascia spazio a chi la pensa diversamente; no, essi vogliono attuare una rivoluzione sociale e anche espandere i confini della rinata Jugoslavia ai danni dell’Italia. Secondo i loro piani, anche Trieste dovrebbe diventare jugoslava.
Ecco perché nelle foibe (o nelle carceri o nei campi di concentramento) finiscono non solo rappresentanti dello Stato italiano sconfitto (poliziotti, carabinieri, ma pure postini, impiegati comunali e così via), ma anche persone benestanti, accusate di essere oppressori del popolo, e poi tutti coloro che potrebbero rappresentare una minaccia per la nascente dittatura. Ed è per questo che vengono eliminati quegli sloveni e quei croati che non vogliono farsi comunisti, come coloro che nella città di Fiume vogliono ricreare un piccolo Stato autonomo, come era stato nei primi anni Venti.
Sono mesi di terrore e per gli italiani dell’Istria e della Dalmazia sembra praticabile solo una strada: fuggire. Si ha paura di restare, si ha paura di essere arrestati, di finire nelle foibe. La gente dell’Istria si imbarca sulle navi per trasferire sulla nostra penisola e ricostruire una vita. Qualcuno spera ancora: si dice, per esempio, che la città di Pola rimarrà all’Italia. Non c’è però niente da fare: il clima di terrore ha già raggiunto la città. Il 18 agosto 1946, una calda domenica d’estate, sulla spiaggia di Vergarolla a Pola qualcuno provoca un’enorme esplosione con almeno un centinaio di morti tra coloro che si godono il mare e il sole. Molti di loro sono bambini. Di più: il trattato di pace che l’Italia sconfitta deve firmare a Parigi il 10 febbraio 1947 impone che tutta l’Istria (oltre a Zara) vada alla Jugoslavia. Anche da Pola inizia la fuga in massa degli italiani.
E così, tra il 1945 e la metà degli anni Cinquanta, a ondate successive, circa 300.000 italiani lasciano le loro case, le loro terre, i loro morti nei cimiteri. Sono loro gli esuli giuliano-dalmati che oggi ricordiamo.
Come vengono accolti questi profughi? Nella penisola ci sono molti episodi di solidarietà, malgrado l’Italia sia in quel momento un paese distrutto e poverissimo. Si cerca di offrire un tetto, di far andare i bambini a scuola, di procurare assistenza e lavoro. Ma non è sempre così, purtroppo.
Pesano infatti i pregiudizi politici e gli schemi ideologici. Il Partito Comunista ritiene che questi profughi siano tutti compromessi con il fascismo, perché altrimenti non scapperebbero dalla Jugoslavia comunista; a destra, invece, i nostalgici di Mussolini cercano di far dimenticare le gravi responsabilità del fascismo nell’aver contribuito a creare un clima di odio da quelle parti. Tutti i partiti si fanno dominare dall’ideologia della contrapposizione tra l’Occidente filoamericano e l’Oriente filorusso.
E la gente comune? Come ho detto, molti si rimboccano le maniche per aiutare i profughi; altri, invece, si fanno imprigionare dai soliti luoghi comuni che ogni volta accompagnano l’arrivo di estranei a casa nostra: i profughi istriani sono sporchi, ci rubano il lavoro, non parlano neppure l’italiano (perché molti si esprimono nel loro dialetto giuliano).
Succede così che tanti profughi giuliano-dalmati decidano di non fermarsi nella penisola e se ne vadano direttamente in Australia o nelle Americhe. Per altri, più fortunati, si costruiscono case e quartieri, come a Roma o come a Fertilia, in Sardegna. Altri ancora rimangono a vivere nelle baracche fino alla metà degli anni Sessanta: è il caso del “Villaggio San Marco”, che riutilizza le baracche del campo di concentramento di Fossoli, già usato dai nazisti per rinchiudervi ebrei e antifascisti.
Oggi, dunque, noi ricordiamo tutti questi avvenimenti e facciamo memoria di tutte queste persone che hanno pagato con la vita o sofferto tante sciagure. Onorare queste vittime significa però anche capire i motivi delle loro disgrazie e impegnarsi a far sì che non si ripetano. Tocca a tutti noi e soprattutto a voi, ragazzi e ragazze, costruire un’Europa migliore di quella attuale, che pure è già tanto migliore di quella del passato: oggi, nel 2022, italiani, sloveni e croati possono convivere amichevolmente nella stessa Unione Europea e possono anche cercare - finalmente - di rivedere insieme e in modo critico il loro passato. Lo hanno fatto, con un gesto simbolico bellissimo, il nostro presidente Sergio Mattarella e il presidente della Slovenia Borut Pahor, quando il 13 luglio 2020 – tenendosi per mano - hanno reso omaggio prima alle vittime italiane della foiba di Basovizza e poi a quattro giovani sloveni fatti fucilare dal regime fascista nel 1930.
Il futuro si costruisce conoscendo il passato, comprendendo gli uni le ragioni degli altri e dando un nome sia alle vittime innocenti sia ai responsabili delle loro sofferenze. Senza reticenze e senza confusioni.