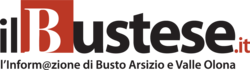Quel "ritornello" mi ha accompagnato per l'intera infanzia e per tutta la mia gioventù. Lo si diceva in casa, lo si ripeteva fuori, quasi fosse un "dogma" da volere spiegare a ogni costo. Eppure (ne parlo con Giusepèn), oltre al significato letterale (agosto: il sole va nel bosco), c'è il significato morale - "il sole che va nel bosco" è abbastanza fantasioso - significa che le giornate iniziano a tarpare le ore della luce e lasciano spazio alle ore della sera, quando il sole va a "dormire" e non ha più la potenza di luce dentro i suoi raggi. Il "bosco" è ritenuto una "casa" dove il sole alloggia e si fa il meritato riposo, dopo i lavori di mietitura, di trebbiatura, eseguiti sotto il solleone, nei campi.
C'è poi il pensiero dell'inverno. Che non è lì "a due passi", ma il contadino previdente, lo deve tenere in considerazione, affinché provveda a spargere il fieno per le bestie da stalla, per poi raccoglierlo in covoni e depositarlo sotto il tetto del portico, per poi essere utilizzato quando il freddo e il gelo non consentono di procurare il "vitto" da utilizzare nella stalla.
Quindi, il caldo d'agosto è premonitore: non agire come la cicala che frinisce "da mane a sera", ma agire come la formica, zitta e operosa, col suo andirivieni fra le zolle, per portare a casa quel che raccoglie nel becco. Agosto è impostato al risparmio. Proprio in quel tempo, in casa si ammoniva di "risparmiare" per avere (in caso di necessità) una risorsa da utilizzare alla bisogna.
Il contadino -poi- doveva spesso "guardò al voltu" (guardare in alto) per scrutare le voluttà del cielo che a volte propinava un temporale o la siccità ed erano "guai" non poter affrontare la situazione, se prima non si era provveduto a "parare il colpo" - irrompe Giusepèn per dire "ul paesàn al droea ul cò, non dumò pandò'n dul barbe" (il contadino, non utilizza la testa solo per andare dal barbiere), ma si esprime ed opera con saggezza .
In agosto, tuttavia, non ci si dedica unicamente a proteggere il proprio lavoro, ma c'è un congruo spazio per rilassarsi, divertirsi, dedicarsi alla compagnia di familiari e amici.
"a cà tua" sentenzia Giusepèn "sut'al pergulò, ul to nonu Pasqualeau cunt'i so tusan; a zia 'Ngiuleta e a zia Teresa, i metea su'n cuncertu cal tiea a pressa tuto'l vicinatu" (a casa tua - sotto il pergolato, tuo nonno Pasquale con le sue figlie, la zia Angioletta e la zia Teresa, montavano un concerto che richiamava il vicinato) - opere liriche, con la voce di baritono del nonno e del soprano delle zie che gli astanti ascoltavano con supremo rispetto - al gorgheggio di qualche tenore che si aggiungeva al gruppo, si viveva un pomeriggio sublime che lasciava poco spazio alle canzonette dell'epoca, come "quel mazzolin di fiori" o "lo spazzacamino" - Giusepèn ci mette un commento, osservando la... pudicizia delle ragazze, ad ascoltare certe "sottolineature" che accompagnavano i versi della canzone... del tipo "prima lo fa entrare, poi lo fa sedere - gli dà da mangiare e bere, su e giù per il camin" - tutti, nessuno escluso, sapeva qual è il nesso della canzone.
Intanto, qualche grillo sostituiva la cicala, nel suo frinire e accompagnava le tenebre a calare sulla "combriccola" che si beava per il "bel canto" - certo, i fiaschi di vino si svuotavano, la parlata diventava "impastata" e gli occhi segnavano l'ora di andarsi a riposare.
Di certo, l'intera notte era dedicata a "morfeo" e inconsciamente, ci si preparava per i lavori del giorno seguente!