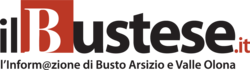Il legnanese Davide Crepaldi è stato protagonista nei giorni scorsi di interviste sui canali Rai durante il programma ElisirTv e su Radio1Rai per parlare del suo nuovo libro “Neuropsicologia della Lettura. Un’introduzione per chi studia, insegna o è solo curioso”. Davide Crepaldi è attualmente un professore associato di Neuroscienze Cognitive presso la Scuola Internazionale superiore di studi avanzati di Trieste (Sissa), dove dirige un gruppo di ricerca e si occupa di lettura, riconoscimento visivo delle parole e apprendimento. Crepaldi ci racconta le ricerche attualmente in corso e gli importanti temi che hanno impatti sulla dislessia e l’apprendimento.
Su quali studi si sta concentrando in questo periodo?
Sto studiando la relazione fra lettura e il cosiddetto apprendimento statistico, cioè la capacità del cervello di accorgersi di registrare le irregolarità statistiche degli eventi intorno a noi. Questo è importante per la lettura, perché implica un insieme di serie di regolarità statistiche, come ad esempio il modo in cui le lettere appaiono assieme: se tu hai una lettera C sai che è molto più probabile che dopo arriverà una A oppure una E, mentre invece è piuttosto poco probabile o quasi impossibile che arriverà una S. Allo stesso modo è meno probabile che arrivi una L, per esempio, che è comunque possibile ma meno probabile rispetto ad una O.
L'idea è che il cervello sfrutti queste regolarità statistiche per velocizzare la propria elaborazione del linguaggio e quindi per renderci dei vettori più efficienti. Noi stiamo facendo una serie di studi con queste ipotesi in mente, che coinvolgono la lettura naturale dei bambini e la misurazione dei movimenti oculari mentre leggono i testi. Abbiamo anche progetti più sperimentali “in senso stretto”, per esempio, ci inventiamo dei lessici artificiali che costruiamo con delle statistiche che disegniamo a tavolino, in particolare: insegniamo ai partecipanti che vengono in laboratorio, a fare questo esperimento/gioco e poi verifichiamo se hanno sviluppato sensibilità a queste regolarità statistiche.
I nostri studi si concentrano anche su tematiche più computazionali di natura: prendiamo dei grossi corpi di linguaggio e calcoliamo queste statistiche. Ci sono altre casistiche molto più complesse, come le probabilità di transizione che si riferiscono a lettere che possono essere affiancate oppure distanti.
Ci sono molte unità nel linguaggio, non abbiamo solo le lettere, ci sono anche le parole che hanno statistiche di concorrenza. Infine facciamo anche un po' di analisi del dato cerebrale, per cui registriamo risonanza magnetica e magnetencefalografia, fino al segnale elettroencefalografico usato anche in ambito clinico per gli esami negli ospedali.
Come è nata l'idea del libro?
In modo completamente casuale in quanto non avevo l’idea di scrivere un libro, finché mi ha telefonato L’Espresso per un’intervista sul rapporto fra lettura sulla carta e lettura sullo schermo, che però non è un mio tipico tema di ricerca. Ho raccontato quello che sapevo ed è venuto fuori un bellissimo articolo a firma di Francesca. Carocci Editore, successivamente, mi ha proposto di scrivere un libro sulla lettura schermo. Abbiamo trovato un’intesa per fare un libro divulgativo, dove trattare le neuroscienze della lettura, con un capitolo dedicato alla lettura su carta e uno dedicato alla lettura su schermo.
Inclusione, come si realizza a livello di apprendimento?
E’ una domanda importante, che richiede di fissare un concetto fondamentale da cui partire, ovvero il linguaggio scritto che è un'invenzione culturale e non un oggetto biologico, in quanto non è emerso spontaneamente nell'evoluzione del genere umano come il linguaggio orale, il camminare e la posizione eretta. Questo significa che il nostro cervello non ha delle strutture plasmate dall'evoluzione biologica della specie per leggere. Abbiamo dovuto apprendere da strutture create per fare altro, come il riconoscimento visivo fondamentalmente degli oggetti che guidano nella lettura.
Dal punto di vista cognitivo e neurocerebrale, la lettura è più difficile delle altre capacità cognitive perché occorre un apprendimento diretto ed esplicito: qualcuno ci deve insegnare a leggere, mentre per parlare impariamo da soli, in quanto è sufficiente essere esposti al linguaggio. Questo genera delle diversità individuali tendenzialmente un po' più marcate, perché nascono delle differenze tra bravi e meno bravi. Essendo una domanda più educativa che cognitiva e non sono sicuro di quale sia l'approccio giusto, perché da un lato certamente capisco la logica dei classici strumenti compensativi e dispensativi.
Faccio alcuni esempi: se non sai leggere perché non hai questo talento naturale, allora io ti faccio fare dell'altro per farti acquisire le informazioni con un metodo alternativo. Ovviamente questo ha un senso, però occorre prestare attenzione al fatto che la lettura essendo uno dei principali strumenti con cui noi plasmiamo le nostre capacità linguistiche, nel breve periodo semplifica la vita al bambino, ma nel lungo periodo potrebbe diventare pericoloso perché si perde uno strumento di allargamento del loro vocabolario e delle loro capacità sintattiche ed espressive.
Quali studi state facendo sulla dislessia?
Io mi occupo più di ricerca di base, in particolare quali sono i meccanismi neurali e cognitivi che ci permettono di leggere, però chiaramente questi studi hanno una certa rilevanza per la dislessia. Per esempio, una delle conseguenze del progetto di ricerca anticipato in precedenza è sicuramente connessa a quello della dislessia: dai primi dati che abbiamo, sembra che le capacità di apprendimento statistico potrebbero essere molto importanti per il riconoscimento visivo delle parole e per la capacità di leggere.
Questo significa da un lato che ci potrebbero essere delle dislessie provenienti in realtà da questo problema, ovvero dalle difficoltà ad apprezzare le relazioni statistiche, quindi non è un problema principalmente genuinamente legato alla lettura: è un'altra capacità cognitiva, questo apprendimento statistico che non funziona tanto bene ed essendo importante per la lettura, la stessa viene un po' colpita. Dall'altro canto vedendola in modo più positivo, potrebbe diventare un elemento di aiuto ai bimbi perché se sappiamo che l'apprendimento statistico aiuta e influenza le capacità di lettura, allora per le dislessie che non riguardano l’apprendimento statistico, noi possiamo cercare di usare l'apprendimento statistico per migliorare le capacità di lettura: per esempio, facendo lavorare i bambini ad acquisire consapevolezza di questa regolarità statistica, oppure semplicemente, esponendoli a quantità di testo piuttosto importanti, in modo tale che il loro cervello registrerà sempre di più queste regolarità e le userà per compensare delle difficoltà che potrebbero avere su altri versanti.
Progetti futuri a Legnano?
Attualmente non ho progetti in cantiere, anche se qualche anno fa prima di lasciare l'Università di Milano Bicocca e trasferirmi alla Sissa, ho fondato un consorzio di professionisti che aveva l'idea di fare attività di ricerca e di intervento per proporsi come partner, alle scuole, ed anche agli enti locali: per esempio, sviluppare progetti che ci avrebbero permesso di raccogliere dati e fare ricerca scientifica, per restituire alla comunità i risultati dei nostri studi. Il progetto non è decollato perché l’interesse dei partner pubblici era sulla parte applicativa clinica piuttosto che a quella di ricerca. Un domani credo che questa idea potrebbe ritornare perché molto utile nelle scuole e si potrebbero fare ragionamenti interessanti.