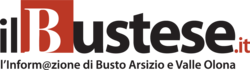Alla buon'ora, Giusepèn "s'è giò in pe?" (sei già desto?) gli dico. Ovvio che do un'occhiata all'orologio e, alle otto del mattino, Giusepèn s'è fatto accompagnare dalla figlia Maria, qui da me. Dopo i saluti, Giusepèn mi spara a raffica i quattro nomi espressi nel titolo. "la ma dì 'na sciua da dighi ma l'è 'l significatu e, men gu dì ca ta lu fo scrìi dul Gigi" (mi ha interpellato una signora per dirle qual è il significato delle quattro parole che ti ho detto e le ho risposto che te lo faccio scrivere da te).
Bene: "ul mùon" è il gelso che serviva proprio per assecondare il lavoro del "baco da seta" che si nutriva proprio dalle foglie di quella pianta - all'epoca, in molte famiglie di Busto, si lavorava per la cura del "baco" che poi si racchiudeva nel bozzolo da lui stesso creato e da lì, si mandavano i "bozzoli" alle aziende che eseguivano l'intera lavorazione, per arrivare al "prodotto finito" che, appunto diventava seta. La città maggiormente produttiva del delicato prodotto, inequivocabilmente era Como!
Il "mudròn" era l'asfalto... "mudròn" era l'intera lavorazione del cosiddetto catrame che serviva per asfaltare le strade - nella mia infanzia, ricordo strade polverose, con dentro solchi prodotti dai carretti tirati dai cavalli; a volte, autentiche fosse per il troppo uso nel passaggio - quando pioveva, le strade erano simili a pantani dentro cui era difficile tenere l'equilibrio, sia per chi circolava in bicicletta, ma pure per i pedoni che dovevano eseguire "slalom" tra pozzanghere e pantano. Col "mudròn" si provvide a rendere le strade più belle e più comode. Ho assistito (lo ricordo tuttora) all'operazione di asfaltatura della via Castelfidardo a Busto Arsizio - quella che incrocia Corso Italia, prospiciente a via Arnaldo da Brescia - c'era folla come allo stadio, lungo tutto il percorso e, lo stupore era dipinto negli sguardi di chi, come me, era testimone dell'evento.
Per l' "ùua" occorre tirare in ballo, l'industria tessile. Allora, i telai erano rudimentali e la navetta che passava nella "trama" produceva quella lanuggine appiccicosa lasciata dal cotone. Spesso, le operaie addette al lavoro, dovevano pulire l'area di passaggio della navetta, per evitare di scaturire "sbreghi" nel tessuto che si produceva - la mia Pierina, diceva sempre con orgoglio "u lauò ventiset'an sui telài" (ho lavorato 27 anni sui telai) - non posso dimenticare un altro ricordo che mi aveva detto mio padre - nonna Luisina, allora diciannovenne, lavorava anch'ella sui telai e, un maledetto giorno, per un caso fortuito, la navetta "deragliò" e colpi la fanciulla che poi sarebbe diventata mia nonna, all'occhio sinistro. Allora, Luisina, "morosava" nonno e, desolata, lei gli disse "mò, Pasqualeau, te me oei pu" (adesso, Pasquale, non mi vuoi più) e, per tutta risposta, il "baldo giovane" le rispose "dighi al to po’ da preparò i corti, ca ta spusu" (riferisci a tuo padre di preparare i documenti, che ti sposo) - nonna aveva 19 anni, nonno, ne aveva 23 e, da lì cominciò... la mia vita! Nonna Luigia e Nonno Pasquale ebbero "vivi" 12 figli (poi, ne rimasero dieci).
Per la "mùua" invece, ci si deve riferire alla buona abitudine che avevano genitori e nonni, nei confronti di figli e nipoti - specie la domenica, quando si andava all'Oratorio, si "passavano in rassegna" genitori e nonni e... bontà loro, consegnavano ai "pargoli" la "mùua" che è la "paghetta" da spendere, dopo raccomandazioni... a finire, nel giusto modo.
Io, la "mùua" la ricevevo da papà e dallo zio Giannino - più o meno era nell'ordine delle 50 lire (a volte 20 e 30 - altre volte, 30 e 20), ma le 50 lire (che a Busto in Dialetto si chiamavano "cinquanta franchi" come se fossero espresse in valuta francese, ma era solo un vocabolo portato qui dai Liguri; un francesismo come altri... che aveva uno specifico valore economico. Che si comprava allora, all'Oratorio? l'ingresso al cinema, ad esempio, con "ul giusu" (liquirizia) e a "faina di mochi" (farina di castagne), oltre alla "gazusa" (gassosa) e "ul persigu" (la pesca) che era un dolce color rosa, con sopra una spolverata di zucchero. "ul persigu" era composto da due "facce piatte" col dorso circolare, sovrapposte, con in mezzo la marmellata.
Giusepèn, saludami a tòo sciua e dighi sa l'è cuntenta" (salutami la tua signora e dille se è contenta (della mia spiegazione). Maria e Giusepèn chiacchierano un po' su "quel che capita", poi salutano e se ne vanno allegri "teme 'na Pascua" (come una Pasqua).