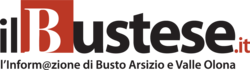Che cosa riesce a fare l’intelligenza artificiale? Luca Mari, professore di scienza della misurazione alla Liuc cattura subito l’attenzione del pubblico dell’Auditorium dell’istituto Cattaneo con un esempio incalzante. A lui spetta dare il la al convegno organizzato dall’Ucid che va a sondare i rischi dell’IA. Attraverso il software Chatgtp mostra “i miracoli” della tecnologia: l’IA riesce a fare una sintesi di un documento, una sintesi su un aspetto più specifico, una sintesi discorsiva rivolta a un particolare soggetto, a un altro destinatario, un test di autovalutazione, approfondimenti, suggerimenti per migliorare, creazione linguistica con frasi stereotipate, creazione di storytelling, scrittura di un comunicato stampa in tutte le lingue.
Dialoga con l’altro docente Alessandro Giordani, professore di logica e filosofia della scienza dell’università Cattolica di Milano. «Le rivoluzioni culturali agiscono a diversi livelli – chiarisce - La rivoluzione culturale dell’IA presenta un nuovo agente sulla scena: è importante assumere un atteggiamento critico». Fa capire che il nostro apprendere procede a tentativi ed errori, con modelli da cui possiamo trarre delle procedure per risolvere dei problemi.
Mari illustra due strategie per la soluzione dei problemi. «Che cosa può accadere se si replica quello che facciamo con una calcolatrice o computer – ribatte Giordani - Il problema è che Chatgpt è in grado di calcolare e deliberare. Che cosa accadrebbe se insieme al calcolo assistito ci troviamo insieme a un pensiero assistito? Delegheremo il nostro pensiero alle macchine?». Mari presenta un rischio grave per i giovani: considerare chatgpt come il migliore amico. «Non siamo sostituibili nella responsabilità sociale nei confronti degli altri – precisa - Un robot non vive. È importante che noi rimaniamo umani affinché la società resti umana».
Modera, Eliana Minelli, prof associata di organizzazione alla Liuc. Chiarisce il tema dell’incontro: l’impatto di questa tecnologia rispetto all’essere uomo. Interviene il rettore Federico Visconti: «L’incontro rientra nelle cosiddette attività di terza missione: far incontrare le persone per farle discutere su diversi temi. L’impatto sulla dialettica di questi mesi riguardo all’intelligenza artificiale è importante: si tratta di un tema caldo, anche all’interno della vita dell’università. Ci si pone il problema dell’impatto dell’intelligenza artificiale sui processi educativi».
Il microfono passa al presidente Ucid Gabriele Fontana. «Abbiamo voluto titolare così per sottolineare l’aspetto umano: all’origine di questo mutamento c’è l’uomo. Ci sono risvolti tecnologici, ma non solo. IA rimanda all’artefice, quindi all’uomo. Possiamo pensare a uno strumento essenzialmente tecnologico, ma la tecnologia dipende dalla cultura, dall’uomo».
Alberto Gambino, professore di diritto privato all’Università degli Studi Europea di Roma e presidente dell’Italian Academy of the Internet Code fa luce sui “Diritti e responsabilità personale, tutela della privacy, tra norme in essere e in divenire”. «Il diritto si interessa delle decisioni di algoritmi quando queste sono prese in autonomia – spiega - Se si disgiunge la volontà contrattuale o altre decisioni, il diritto si pone problemi: si aprono dilemmi ad esempio a chi imputare la responsabilità se è un algoritmo a ragionare o costruire qualcosa». Illustra poi l’aspetto importante della protezione dei dati personal e dei diritti d’autore, la creatività.
“Le intelligenze e l’intelligenza. Tra complementarità e differenza” è il titolo dell’intervento di don Lorenzo Voltolin, docente di sistemi teologici e sistemi digitali, Facoltà Teologica del Triveneto. L’argomentazione ruota sulla possibilità delle macchine di sostituire l’uomo: «L’intelligenza umana è un unicum. La macchina non è mai performante, non è in grado di processare una molteplicità di referenti fisici, non è capace di crea un processo per cui si passa dalla sintassi al significato. L’intelligenza umana è irriducibile, anche se non riproducibile».
Luciano Traquandi, docente di psicosociologia aziendale della Liuc e condirettore del Percorso Executive Spem (Spiritualità e Management), Politecnico di Milano School of Management inquadra il discorso su “Sacro e profano, un’interazione complessa?”. «Sacro e profano possono interagire se si considerano nella loro complessità. L’IA sotto l’aspetto profano è una prateria sterminata che ci promette risultati inimmaginabili. Per il sacro il fattore è l’uomo. Sacro e profano possono interagire migliorandosi». E conclude con una citazione: «Noi non trattiamo in un certo modo un oggetto perché è sacro, ma è sacro perché lo trattiamo in un certo modo».
Al termine, dibattito con il pubblico e conclusioni affidate a don Omar Cappelli, assistente ecclesiastico della Liuc.