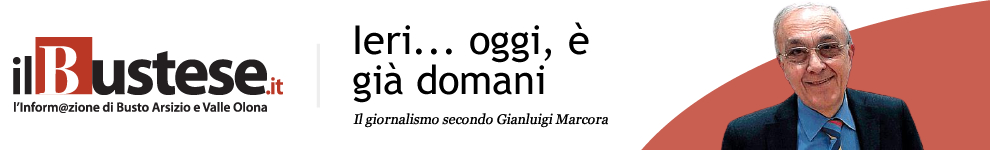Col termine "sta schisciu" (stai sereno, tranquillo), si può aprire un dialogo. Fatto è che non significa solo "tranquillo" o "stai sereno", ma si può benissimo estenderlo a un "resta al tuo posto", o "non pavoneggiarti troppo", "non essere borioso", "non vantarti" e via su questo tono. Chi non è (o non sta) "schisciu" è semplicemente una persona fuori posto o che non sta alle regole o che vuole apparire più di esserci e non possedere quella dote di umiltà che lo renderebbe simpatico e bene accetto dalla comunità.
Balza in scena, Giusepèn: "tan paol par dì che a sta schisciu s'è dàa parti giusta" (tante parole per dire che a essere umile si è dalla parte giusta) ed è proprio qui che si nobilita una parola in uso fra le persone mature. Succedeva (e succede) che di fronte a una "farfanteria" si dice "stà schisciu" per far ritornare l'esagerato nell'alveo della normalità e per ricondurre il dialogo nel novero della giusta discussione. Possiamo fare qualche esempio …."l'e mèi" (è meglio) dice Giusepèn e va dritto a dire che quando qualcuno è avvezzo a esagerare, occorre bloccarlo con un "stà schisciu".
Il cacciatore, ad esempio che parla delle lepre uccisa di 5 … 6 chili o del pescatore che illustra il pesce che ha abboccato alla sua canna da pesca, lungo 25 …30 cm che dopo uno "stà schisciu" sono costretti a …. ridimensionare peso e lunghezza delle loro prede. Ne segue una battuta che consente ai due di "salvarsi", magari …. "arrampicarsi sui vetri" (rampegò sui vedar) con un salomonico "quando tu avrai ridotto la misura del tuo pesce pescato, io diminuirò il peso della lepre che ho ucciso. E questi discorsi, "i fan ingni ul laci ai ginogi" letteralmente "fanno venire il latte alle ginocchia" per manifestare la pochezza delle rispettive tesi. Il "latte alle ginocchia" non è il frutto di una mungitura, ma è semplicemente il "latte" che si forma nelle arti inferiori, dopo uno sforzo o una fatica prolungata …. molto fastidiosa, come è fastidioso sentire la megalomania di taluni.
Giusepèn mette in mostra, poi un detto che fa un po' sorridere: "chi ga mangia'n pè ga n'à mai a se" che tradotto in italiano dice "chi mangia in piedi non ne ha mai abbastanza". E qui si va ai momenti della gioventù, quando per correre in fretta a giocare, si prendeva un panino (magari con dentro la mortadella o "ul salam crùu") e lo si inghiottiva correndo, per far presto a mettersi in compagnia.
Poi, però, la fame si faceva sentire e, al panino ne seguiva un altro che ha fatto scaturire quel "l'e mai a se" (non è mai abbastanza) dedicato al detto di cui sopra. Vero che talvolta, nei fast-food si mangia in piedi o appoggiati a uno sgabello, ma -diciamolo- non è la stessa cosa per chi sprigionava tanta voglia per aggregarsi alla compagnia.
Giusepèn, al "tia a ca'l co" (tira a casa la testa, nel senso che sta ragionando), per dire che "ai me tempi" (ai miei tempi), quando si mangiava fuori casa, per lavoro o per non fare avanti e indietro dal "loegu" (la campagna, il luogo) si portava il pranzo appresso "dentu'l scartozzo o in dàa ramina" (dentro un involucro di carta o nella ramina, la cosiddetta schiscetta). Però, non lo si consumava in piedi, ma "a pusi" (al riparo) di un pergolato o all'ombra delle foglie di un albero rigoglioso, ma pure in un angolo tranquillo, vicino al campo di grano, pronti per potere riprendere il lavoro.
"Nogn, Giusepèn, sem pronti pàa'l Nocino, in cò, in cumpagnia" (Noi, Giusepèn siamo pronti per un Nocino, in casa, in compagnia).