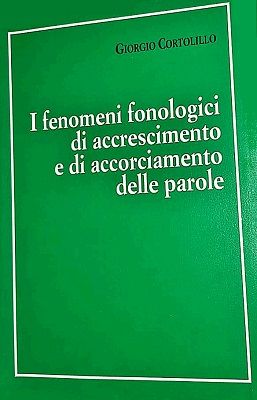Oggi affrontiamo il problema del "troncamento" sempre in ossequio al prof. Giorgio Cortolillo, autore del libro riguardante i "fenomeni fonologici". Facciamo subito alcuni esempi: Castel Mola, ove siam soliti trascorrere gran parte dell'estate, si affaccia sul mar Ionio. Le parole ridotte "castel, siam, gran e mar" adoperate in luogo delle parole intere "castello, siamo, grande e mare" a cui equivalgono, presentano la caduta delle terminazioni "lo, o, de, ed, e" per troncamento.
Il troncamento (dal latino abscissio - onis), sopprime foneticamente e graficamente una vocale o una sillaba atona, purchè preceduta da l,n,o,r, alla fine di una parola plurisillaba che si trova nel corpo di un sintagma, davanti a un'altra parola iniziante per consonante Castel(lo Mola - siam(o) soliti - gran(de) parte - o per vocale, mar(e) Ionio.
Il troncamento rifiuta il segno paragrafematico dell'apostrofo che contrassegna sempre l'elisione, talora l'aapòcope e raramente l'afèresi.
Il troncamento è frequente, ma limitato a un ristretto numero di parole - è un fenomeno fonologico, perché accorcia il significante fonico e grafico di una parola (sant o san), ma anche sintattico, perché nasce dall'incontro di due parole così concordate fra loro da formare un'unità sintattica, cioè un sintagma nominale - quel(lo) rumore o verbale - suol(e) echeggiare - o preposizionale - fin(o) laggiù.
Il troncamento è subordinato al verificarsi di determinate condizioni purchè sia compiuto.
Il troncamento si compie secondo le regole grammaticali prescritte per produrre buon suono (eufonia), nel corpo di un sintagma. Per esempio, si compie nel sintagma "buono uomo" che, troncato diventa l'eufonico "buon uomo", ma non si può compiere in contrasto con la grammatica nel sintagma "cattivo uomo" che, se fosse troncato, diventerebbe il cacofonico "cattiv uomo".
Il troncamento si compie in una parola plurisillaba, cioè in un sostantivo singolare maschile uscente in "e" o in "o", come in signor(e) Angelo, figliuol(o) prodigo o eccezionalmente in un sostantivo femminile - suor(a) Teresa, nell'articolo "uno" - un(o) dipinto o in un suo composto, come in ciascun(o) mosaico, in un aggettivo singolare - buon(o) libro, tal(e) gaudio, qual(e) duolo, gran(de) rumore, bel(lo) film,quel(lo) romanzo, san(to) Francesco, in un verbo all'infinito - fuggir(e) via o all'indicativo - suol(e) essere, in un avverbio - ancor(a) oggi o in una preposizione - fin(o) lassù.
Il troncamento si compie accorciando nella pronunzia e nella grafia (senza aggiunta di apostrofo) una parola plurisillaba per sottrazione dell'elemento finale atono, che può essere vocalico " a e o" sia davanti a consonante - suo(a) Maria sia davanti a vocale - dottor(e) Edilio o sillabico "de, lo, no, to", davanti a consonante soltanto - gran(de) cuore, castel(lo) Gandolfo, han(no) pensato, san(to) Tommaso. La forma ridotta che ne risulta è detta "forma troncata" (esempio suor).
Il troncamento si compie quando la parola da troncare è plurisillaba (esempio signor(e) - finisce in focale atona - figliuol(o) - ha prima della vocale o della sillaba che cade, una consonante liquida , l o r oppure una consonante nasale -m- oppure n preceduta a sua volta da una vocale ,come per esempio in bel(lo), siam(o) e gran(de), ma fuori della norma , può avere prima della sillaba che cade, la vocale "a" preceduta dalla consonante "r" nel sostantivo fra(te) - è unita a un'altra parola, monosillaba o polisillaba che inizia per vocale come alcun(o) ohm, ciascun(o) elettrodo o per consonante tranne gn, ps, s complicata, x e z - esempio - nessun(o) re, quel(lo) ministro.
Fermiamoci qui (anzi, tronchiamo qui): il discorso sul troncamento … non è ancora finito. Sarà per un'altra volta, il prosieguo del discorso.